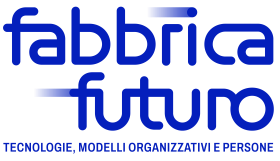Dove va il Manifatturiero nel Sud?

La fine della globalizzazione
Il servizio di copertina di un recente numero di The Economist (8-13 ottobre 2023) titolava: “Are free markets history?. The rise of homeland economics”. I primi a muoversi massicciamente su questo tema sono stati gli Usa, che con una serie di provvedimenti legislativi hanno stanziato enormi risorse per aumentare l’indipendenza industriale del paese (come, in passato, avevano fatto incoraggiando l’estrazione di shale oil e shale gas per aumentare la sua indipendenza energetica). Ciò ha invertito il consolidato trend alla de-materializzazione (terziarizzazione) dell’economia statunitense. Gli investimenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, che nei primi anni ’80 pesavano per quasi lo 0,8% del Prodotto interno lordo (Pil) Usa, e si erano progressivamente ridotti fino allo 0,3% nel 2021, nel 2023 sono risaliti a quasi lo 0,6%. Anche l’Europa si sta muovendo – sia pure in termini più prudenti – su strade analoghe. All’iniziativa Next Generation EU, che in Italia ha dato vita al PNRR, e che, pur non essendo esplicitamente indirizzata all’indipendenza produttiva, ne è comunque una modalità di finanziamento, si sommano iniziative individuali dei singoli paesi, in particolare della Germania, che sta impiegando notevoli risorse a favore della localizzazione (e/o rilocalizzazione) in patria di importanti produzioni. Tutto ciò si somma alle iniziative di backshoring (cioè di ritorno dall’offshoring produttivo) e reshoring (trasferimento in altra location, sempre estera, di attività già esportate) già in atto da parte di molte imprese, in base a vari fattori: aumentato costo dei trasporti, cattiva qualità delle produzioni trasferite, dinamiche salariali differenziate, ecc. Secondo una recente indagine del Politecnico di Milano e del centro Studi di Confindustria al 2021, il 30% circa delle imprese interpellate che avevano delocalizzato ha dichiarato di aver già realizzato un cambiamento di strategia a riguardo; il 16,5% attuando un backshoring totale o parziale. A livello mondiale, ha fatto scalpore l’annuncio che la Apple starebbe spostando parte della produzione degli i-phone dalla Cina all’India. E i “rinoceronti grigi”? L’Intelligenza Artificiale (o, meglio e più in generale) l’automazione costituisce da anni un mistero, per i suoi impatti sul fronte occupazionale. Assistiamo così alla contraddizione di ragionevolissime preoccupazioni sugli effetti di sostituzione che questa sta avendo nei confronti di tanti lavoratori, e le statistiche che registrano significativi cali della disoccupazione in molti ambiti: a livello aggregato G7, il tasso di disoccupazione, che negli ultimi 30 anni oscillava intorno al 6-7%, è sceso a meno del 4%. Già nel 1987 l’economista premio Nobel Robert Solow aveva rilevato il paradosso affermando: “si può vedere l’era dei computer dappertutto, tranne che nelle statistiche di produttività”. Sia pure in termini sostanzialmente modificati, a livello aggregato ciò sembra ancora sostanzialmente vero. Quello che possiamo certamente affermare è che la relazione tra intelligenza artificiale, automazione ed occupazione è estremamente complessa e variegata: ciò significa che, a fronte di settori produttivi che dovranno affrontare gravissimi problemi, altri ne verranno notevolmente avvantaggiati. Anche per il secondo “rinoceronte grigio” gli effetti si presentano in prospettiva estremamente differenziati e diversificati, per area geografica e settore produttivo, con impatti pesanti sugli equilibri industriali (dalle auto a combustione interna a quelle elettriche, dalle caldaie a gas alle pompe di calore, ecc.). Secondo il Rapporto Regionale Confindustria Cerved 2022, il 10,8% delle PMI italiane sono “a rischio molto alto o alto” per climate change, con una notevole diversificazione geografica: il 18,8% al nord-est, il 5,5% al nord-ovest, il 15,7% al centro, e il 3,4% al sud.Le sfide per la Manifattura in meridione
In tutto ciò come si colloca il settore manifatturiero italiano, ed in particolare meridionale? Secondo un recente studio SRM-CESDIM (2022), sono 91.969 le imprese manifatturiere meridionali, un quarto delle 367.358 imprese italiane. Se l’Italia è seconda solo alla Germania per produzione manifatturiera, Il Mezzogiorno, da solo, è settimo nel ranking europeo per numerosità di imprese manifatturiere, tra Spagna (168.689) e Slovacchia (77.085). La numerosità delle imprese italiane (e meridionali) è però anche il suo tallone d’Achille, essendo l’altra faccia della medaglia della piccolissima dimensione media: troppe imprese “nane”, che non possono, o non vogliono, crescere; ed il fenomeno non sembra volersi invertire, anzi tende a consolidarsi. Per fare un esempio: in Puglia, secondo l’ISTAT, tra il 2018 e il 2021 la quota di lavoratori occupati nelle imprese della classe 3-9 addetti è cresciuta dal 43,1% al 44,5%, mentre per le imprese con più di 100 addetti è calata dal 21,0% al 18,7%. Facendo un raffronto con la Germania, si vede che in questo paese il 29,6% delle imprese manifatturiere ha più di 10 addetti, contro solo il 16,0% per l’Italia (dati 2018). Esaminando le rispettive produttività per addetto, si rileva che siamo significativamente più produttivi del dato complessivo dei tedeschi nelle imprese di dimensione media (soprattutto la fascia 50-249 addetti), all’incirca alla pari per quelle di grande dimensione (oltre 250 addetti), ma significativamente al di sotto per quelle (molto più numerose da noi) di piccola dimensione. Naturalmente questi sono valori medi, e le condizioni operative sono molto differenziate in base al settore industriale di operatività. Ma non si può negare che “size matter” rispetto a molte variabili dei sistemi produttivi. Nel 1973 (altro anno di profondi sconvolgimenti, con il primo shock petrolifero in atto) l’economista Ernst Friedrich Schumacher ebbe molto successo con un libro dal titolo “Piccolo è bello”, al quale il Prof. Gianfranco Dioguardi ribatté affermando: “ma grande, a volte, è necessario”, sottolineando l’indubbio peso delle economie di scala. È innegabile, inoltre, che il livello di managerialità nelle imprese cresce, a parità di altre condizioni, con il crescere delle loro dimensioni. Secondo una recente indagine internazionale (World Management Survey) condotta in 20.000 organizzazioni (medie imprese, ospedali e scuole), il livello di managerialità registrato in Italia è risultato ultimo tra i paesi del G7. Ciò è particolarmente vero nell’attuale congiuntura, che vede i mercati in perenne, e spesso rapidissima, evoluzione. Come può difendersi, nella competizione internazionale, il sistema manifatturiero meridionale? Sono note le condizioni operative in cui si trova ad operare, che lo vedono handicappato – rispetto al resto del paese, e – ancor più – agli altri paesi europei, in ambiti come le infrastrutture, la logistica, il costo del denaro. Ciò significa che può puntare sempre meno sulla concorrenza prettamente economica.Investire su qualità ed esclusività
Come è noto, la teoria economica tra gli estremi della concorrenza perfetta (come è usualmente quella delle commodity) ed il monopolio (sogno di ogni industriale) colloca un range continuo di concorrenza monopolistica, all’interno del quale si pone, di fatto, la quasi totalità delle produzioni industriali. Quanto più il nostro prodotto si avvicina all’estremo monopolistico (differenziandosi molto, quindi, da quelli dei concorrenti), tanto meno il suo successo dipenderà dal prezzo, e tanto più da fattori come qualità, esclusività, adattabilità alle esigenze del cliente. Realtà industriali pugliesi quali Mermec e Masmec incontrano il successo internazionale proprio per l’elevato livello di “esclusività” dei loro prodotti. Ciò è possibile anche a livello dimensionale inferiore (ma non certo nella fascia 3-9 addetti), a condizione di poter investire in ricerca e tecnologia, ma anche in design e marketing. Tutti ambiti nei quali un minimo di economie di scala è irrinunciabile. Il mercato globale è attualmente un oceano nel quale le imprese, come fossero singoli natanti, devono affrontare condizioni intrinsecamente imprevedibili, spesso con fenomeni di particolare intensità. Come navigare? Se i colossi multinazionali sono assimilabili a grandi navi portacontainer che seguono la rotta ottimale (ortodromica), e per le quali una burrasca è al più causa di qualche disagio e un po’ di ritardo, le piccole-medie imprese della realtà produttiva italiana, e in particolare meridionale, sono come fragili velieri, che devono adattare la rotta, volta per volta, alle mutate condizioni. Ciò non significa, naturalmente, navigare “a casaccio”, ma piuttosto cambiare il percorso per ottimizzarlo rispetto alle mete che si vogliono raggiungere. Diceva Seneca: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”, ed il “vento” delle mutevoli condizioni di mercato può essere contrario, ma ciò non rende impossibile il raggiungimento della meta, che si fa però più difficile (secondo i velisti francesi “bolina: due volte il tempo, tre volte la fatica”). Ma il vento può anche essere favorevole: i velisti che vogliono battere i record nella traversata atlantica attendono l’arrivo di una burrasca con il vento a favore. Fuor di metafora: i macroeventi imprevedibili possono anche dimostrarsi congiunture positive; pensiamo ai produttori di mascherine e di altri presidi sanitari durante la pandemia, o (purtroppo) ai produttori di armi che, anche in Italia, stanno registrando eccezionali picchi di domanda: nel periodo 2018-2022 le esportazioni sono aumentate del 45% rispetto al 2013-17. Cosa quindi è possibile consigliare alle nostre piccole e medie industrie? Innanzi tutto cercare di raggiungere una dimensione adeguata al proprio mercato di riferimento, il che non significa diventare necessariamente grandi, ma raggiungere la dimensione minima per poter investire in tecnologia e ricerca (ma anche in design e marketing), facendo ricorso il più possibile ai finanziamenti pubblici, come il PNRR ed alla collaborazione con le istituzioni di ricerca pubbliche, in primis Politecnici ed Università. E quindi essere sempre attenti ad avvertire i primi segnali di mutamento ed a cogliere le occasioni favorevoli. L’unica certezza che oggi abbiamo è l’aumentata consapevolezza dell’intrinseca imprevedibilità degli scenari in cui ci troveremo ad operare: grandi rischi quindi, ma anche grandi opportunità.
Nicola Costantino (Bari, 1951), ingegnere, è Professore Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale presso il Politecnico di Bari, del quale è stato Rettore dal 2009 al 2013. Autore di circa trecento pubblicazioni a carattere internazionale e nazionale, prevalentemente sui temi del Supply chain management e del Construction management, ha svolto attività di ricerca e didattica in Usa, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Cina. In qualità di Direttore tecnico di una delle maggiori imprese generali di costruzioni italiane, ha curato la realizzazione di importanti opere di ingegneria industriale e civile in Puglia e Basilicata (centrale Enel di Brindisi Sud, numerose centrali telefoniche, centri di meccanizzazione postale, nuova chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ecc.). È stato consigliere di amministrazione di Tecnopolis Novus Ortus e del Centro Laser di Bari. È stato Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese Spa dal 2014 al 2016 e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Retegas Bari Spa dal 2016 al 2021. Attualmente è componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
globalizzazione, manifattura, sud italia, supply chain